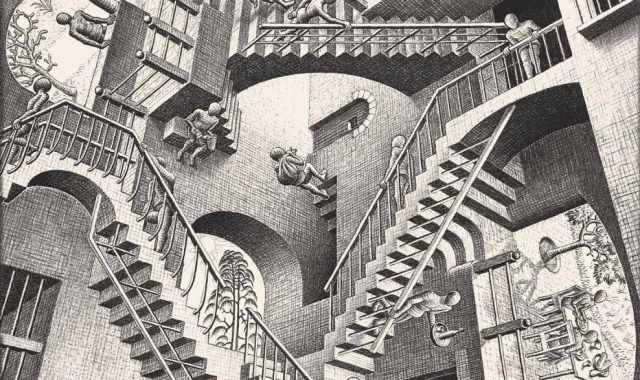Le Cosmicomiche: 12 racconti per scoprire il Calvino fantastico e umoristico
Letto: 1848 volte
martedì 25 luglio 2017
Letto: 1848 volte
Come è nato l’universo? Qual è la nostra origine? Chi siamo? Nel corso della nostra storia queste domande hanno trovato narrazioni fatte di numeri e simboli per codificare quello che c’era da capire, e di versi per narrare quello che c’era da raccontare. Qualcuno ha provato a tracciare segni incisi sulle pareti di roccia delle grotte per dare un senso a ciò che vedeva, altri si sono spinti più in là mandando messaggi e sonde perché qualcuno dall’altra parte del sistema solare potesse rispondere.
Italo Calvino, avvezzo al viaggio e agli spostamenti, ci ha provato con le parole, raccontando nelle sue Cosmicomiche un viaggio attraverso lo spazio e il tempo del nostro universo, non per spiegare, ma per narrare con la stessa magia dei narratori dell’antichità che sotto un cielo carico di stelle raccontavano la storia del mondo: inventando, ridendo e abbellendo le loro storie del fascino senza tempo dei racconti mitici.
L’opera consta di dodici racconti scritti da Calvino tra il 1963 e il 1964 e ha per protagonista il giovane, vecchio, indefinibile e impronunciabile Qfwfq. Lui è di volta in volta un mollusco, un dinosauro, un vertebrato appena uscito dalle acque primordiali di un mondo, il nostro, in evoluzione. Ma ciò che conta qui non sono i protagonisti, ma la narrazione stessa.
La galassia, l’universo, il big bang, sono la mappa in continua trasformazione su cui Calvino trascrive le avventure dei vari personaggi che affiancano Qfwfq ed è così che, racconto dopo racconto, si dipana la storia intera del cosmo.
In “Tutti in un punto” incontriamo Qfwfq e altri personaggi ridotti a vivere in un unico luogo infinitamente piccolo, adimensionale e senza parti. Ovviamente c’è poco spazio per muoversi, poco spazio per fare amicizia e le interazioni sociali sono ridotte all’osso. In questo racconto ci penserà la signora Ph(i)Nko a risolvere questa inospitale impasse, esclamando: “Ragazzi, avessi un po’ di spazio, come mi piacerebbe farvi le tagliatelle!”, ed è così che allargando le braccia tutti gli altri abitanti del punto vengono sbalzati fuori e proiettati ai quattro angoli dell’universo. Vi ricorda qualcosa? Ad esempio Hubble e la velocità di allontanamento delle galassie, tradotta da Calvino in una storia divertente e surreale.
“Quanto scommettiamo?”. Nel corso di miliardi di anni Qfwfq e l’altro protagonista, il Decano (k)yK, si sfidano scommettendo su qualunque corpo celeste, gruppo di atomi, stelle di neutroni gli capiti a tiro. La trama sembra costruita sulla dinamica di una partita a blackjack europeo e Qfwq adotta una strategia standard che gli permette fin all’inizio di avere ragione sul vecchio decano, troppo lento nel calcolare gli imprevedibili eventi futuri di un universo in continua trasformazione. Come in una partita di blackjack, una buona strategia permette di ottimizzare i risultati, ma non di prevedere l’esattezza degli stessi, così il nostro campione si troverà a dover affrontare quesiti sempre più imprevedibili vedendo così diminuire il suo vantaggio. E qui entra in gioco la cibernetica, con le sue retroazioni positive e negative.
La mappa che costruisce Calvino diverte e cattura per la sua apparente distanza dal mondo umano, ma è proprio da questa distanza che ci rimanda indietro come un telescopio guardato dal lato giusto tutte le contraddizioni, i sentimenti e le emozioni dell’uomo. Così in “Gli anni-luce”, il problema di comunicazione tra due galassie lontane si traduce nel problema più che mai attuale delle difficoltà di comunicazione e interazioni sociali. Mentre ne “I dinosauri” il tema di fondo è l’accettazione di sé stessi. Qui incontriamo il dinosauro Qfwq appena scampato ad una terribile estinzione dopo avere trovato rifugio su di un altopiano deserto. Una volta sceso avrà di fronte un mondo completamente cambiato in cui a dominare saranno i “Nuovi “. Ci vorrà del tempo prima che riesca ad integrarsi, ma soprattutto ad accettare la propria diversità.
È in questo cosmo per nulla serio, ma anzi terribilmente comico che il senso iniziale di straniamento lascia spazio al riconoscimento perché in fondo è proprio di noi e della nostra umanità che Calvino sta parlando.
Italo Calvino, avvezzo al viaggio e agli spostamenti, ci ha provato con le parole, raccontando nelle sue Cosmicomiche un viaggio attraverso lo spazio e il tempo del nostro universo, non per spiegare, ma per narrare con la stessa magia dei narratori dell’antichità che sotto un cielo carico di stelle raccontavano la storia del mondo: inventando, ridendo e abbellendo le loro storie del fascino senza tempo dei racconti mitici.
L’opera consta di dodici racconti scritti da Calvino tra il 1963 e il 1964 e ha per protagonista il giovane, vecchio, indefinibile e impronunciabile Qfwfq. Lui è di volta in volta un mollusco, un dinosauro, un vertebrato appena uscito dalle acque primordiali di un mondo, il nostro, in evoluzione. Ma ciò che conta qui non sono i protagonisti, ma la narrazione stessa.
La galassia, l’universo, il big bang, sono la mappa in continua trasformazione su cui Calvino trascrive le avventure dei vari personaggi che affiancano Qfwfq ed è così che, racconto dopo racconto, si dipana la storia intera del cosmo.
In “Tutti in un punto” incontriamo Qfwfq e altri personaggi ridotti a vivere in un unico luogo infinitamente piccolo, adimensionale e senza parti. Ovviamente c’è poco spazio per muoversi, poco spazio per fare amicizia e le interazioni sociali sono ridotte all’osso. In questo racconto ci penserà la signora Ph(i)Nko a risolvere questa inospitale impasse, esclamando: “Ragazzi, avessi un po’ di spazio, come mi piacerebbe farvi le tagliatelle!”, ed è così che allargando le braccia tutti gli altri abitanti del punto vengono sbalzati fuori e proiettati ai quattro angoli dell’universo. Vi ricorda qualcosa? Ad esempio Hubble e la velocità di allontanamento delle galassie, tradotta da Calvino in una storia divertente e surreale.
“Quanto scommettiamo?”. Nel corso di miliardi di anni Qfwfq e l’altro protagonista, il Decano (k)yK, si sfidano scommettendo su qualunque corpo celeste, gruppo di atomi, stelle di neutroni gli capiti a tiro. La trama sembra costruita sulla dinamica di una partita a blackjack europeo e Qfwq adotta una strategia standard che gli permette fin all’inizio di avere ragione sul vecchio decano, troppo lento nel calcolare gli imprevedibili eventi futuri di un universo in continua trasformazione. Come in una partita di blackjack, una buona strategia permette di ottimizzare i risultati, ma non di prevedere l’esattezza degli stessi, così il nostro campione si troverà a dover affrontare quesiti sempre più imprevedibili vedendo così diminuire il suo vantaggio. E qui entra in gioco la cibernetica, con le sue retroazioni positive e negative.
La mappa che costruisce Calvino diverte e cattura per la sua apparente distanza dal mondo umano, ma è proprio da questa distanza che ci rimanda indietro come un telescopio guardato dal lato giusto tutte le contraddizioni, i sentimenti e le emozioni dell’uomo. Così in “Gli anni-luce”, il problema di comunicazione tra due galassie lontane si traduce nel problema più che mai attuale delle difficoltà di comunicazione e interazioni sociali. Mentre ne “I dinosauri” il tema di fondo è l’accettazione di sé stessi. Qui incontriamo il dinosauro Qfwq appena scampato ad una terribile estinzione dopo avere trovato rifugio su di un altopiano deserto. Una volta sceso avrà di fronte un mondo completamente cambiato in cui a dominare saranno i “Nuovi “. Ci vorrà del tempo prima che riesca ad integrarsi, ma soprattutto ad accettare la propria diversità.
È in questo cosmo per nulla serio, ma anzi terribilmente comico che il senso iniziale di straniamento lascia spazio al riconoscimento perché in fondo è proprio di noi e della nostra umanità che Calvino sta parlando.