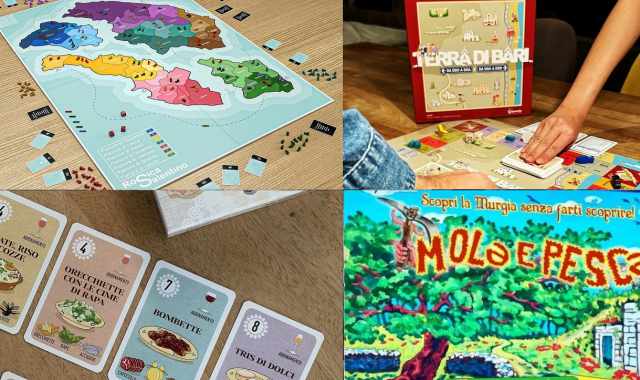Le secolari cantine del sud-est barese, lì dove si produce il sontuoso Primitivo di Gioia
Letto: 9597 volte
martedì 6 luglio 2021
Letto: 9597 volte
di Gabriella Mola - foto Antonio Caradonna
Come detto fu a Gioia del Colle che il sacerdote don Filippo Francesco Indellicati apprezzò per primo le caratteristiche del vitigno a cui diede il nome di “primativo”, dal latino primativus, che vuol dire “precoce”. Il prelato infatti notò che le sue uve maturavano in anticipo rispetto a quelle delle altre viti.
Il prodotto però, nonostante la sua origine barese, si diffuse e si fece conoscere soprattutto nel tarantino. La “svolta” arrivò nel 1881, anno in cui la contessa Sabini di Altamura si sposò a Manduria con Tommaso Schiavoni Tafuri, portando come dote le barbatelle di primitivo.
A sud-est di Bari fu invece a lungo utilizzato solo per “tagliare” altri nettari o per essere venduto sfuso. Questo fino a una ventina d’anni fa, quando il mercato enologico è cresciuto significativamente e le aziende hanno cominciato finalmente anche a imbottigliare.
Siamo quindi andati a visitare le tre più antiche cantine produttrici di Primitivo di Gioia, portate avanti dalle stesse famiglie da decenni e decenni: si tratta delle secolari Colavecchio (a Putignano dal 1795), Patruno Perniola (a Gioia dal 1821) e Angiuli (ad Adelfia dal 1880). Della lista farebbe parte anche Chiaromonte (ad Acquaviva dal 1826), che però non ha voluto rilasciare dichiarazioni. (Vedi foto galleria)
Cominciamo da Colavecchio, situata nelle campagne di Putignano. Veniamo accolti da una masseria a un solo piano verniciata di rosso pompeiano e ornata da una vite rampicante. In un angolo riposano un vecchio torchio, alcuni aratri e delle botti ornamentali.
A venirci incontro è la 50enne Rosalba Colavecchio, discendente della famiglia alla settima generazione: fu infatti il suo avo Francesco Saverio a dare il via all’impresa dopo avere sposato la proprietaria terriera putignanese Gesualda Accetto.
Ed è proprio la “vecchia vigna”, quella impiantata dal fondatore, a fornire l’etichetta di punta dell'azienda: una bevanda di 15 gradi di colore rosso rubino intenso. «Produciamo circa 13mila quintali di uva ogni anno che trattiamo in maniera poco invasiva, utilizzando il meno possibile trattamenti chimici – spiega la signora –, anche se in prevalenza continuiamo a vendere vino sfuso».
Nella cantina, cuore della tenuta situata a 5 metri di profondità e posta in un ambiente in pietra con soffitto a volta, si trovano bottiglie invecchiate e sigillate con la ceralacca e soprattutto botti in legno di rovere francese utilizzate da duecento anni. «La veneranda età che si fa però sentire – sottolinea Rosalba –: alcune sono deformate, altre presentano fori, per questo le usiamo solo per brevi passaggi».
Questa fase è anticipata dalla vinificazione in vasche di cemento rivestite di vetroresina un tempo costruite assieme alle cantine. Un metodo ormai generalmente caduto in disuso perchè costoso e di difficile manutenzione, soppiantato dai moderni silos in acciaio. «Noi però ce ne serviamo ancora perchè risentono meno degli sbalzi termici, permettendo al vino di rimanere più protetto, integro e fedele alle sue caratteristiche principali», afferma con fierezza la titolare.
Salutiamo Rosalba e ci dirigiamo nell’agro di Gioia del Colle per visitare la Tenuta Patruno Perniola. Siamo in collina, a circa 350 metri d’altezza: qui il terreno roccioso e minerale fornisce i nutrimenti che arricchiscono i grappoli. Restiamo subito colpiti dai filari della vigna e dalla candida masseria che quest'anno festeggia i due secoli dalla fondazione.
Una verandina ripara una serie di oggetti contadini, tra cui due “capasoni”, antiche giare in terracotta per la conservazione di vino o olio. Veniamo raggiunti dal 50enne Paolo Patruno, medico che ha lasciato la sua professione per dedicarsi interamente alla tenuta ereditata da sua nonna Paola dieci anni fa.
«I miei nonni materni vivevano e vinificavano qui - racconta con orgoglio l’uomo -. I sette ettari di vigneto presenti sono quasi interamente coltivati “ad alberello”, caratterizzato da un tronco piccolo e basso tipico del primitivo. Ne ricavo circa 12mila bottiglie annue».
Paolo esegue l'aratura manuale almeno due volte all'anno con l'ausilio dei cavalli, per assicurarsi che le radici si sviluppino in verticale assorbendo nutrimento e sali minerali e tratta l’uva con metodi naturali come la cera d'api, che non incidono sulla linfa della pianta. «Tutto ciò si traduce in un prodotto autenticamente genuino», afferma.
La cantina, ristrutturata nel 2006, si trova alla sinistra della masseria e ospita i silos in acciaio. Ogni cisterna conserva un certo tipo di vino, originario di diverse zone della vigna poste a differenti latitudini. «Il frutto coltivato in un’area più elevata restituisce un primitivo di 14 gradi, violaceo, con un profumo intenso di mosto e un sapore più aspro – evidenzia l’uomo –. Al contrario, quello cresciuto più in basso conferisce mezzo grado in più e maggiore morbidezza e dolcezza».
L’ultima tappa del nostro viaggio sulla “via del primitivo” ci porta alla cantina Angiuli di Adelfia, in un palazzo posto in via Principe Umberto 47. «I nostri 20 ettari di coltivazione si trovano dislocati negli agri limitrofi», ci spiega il 30enne Vito, che gestisce l’impresa col fratello Giuseppe.
L'attività nasce nel 1880 con il bisnonno Donato, bravissimo innestatore conosciuto in tutto il Meridione. «Per fare un esempio la nostra famiglia ha portato la tradizione del tendone a protezione delle vigne fino in Abruzzo», sottolinea il titolare.
A partire dagli anni 80/90 del 900 gli eredi hanno però dato una marcia in più all’azienda, passando dal vino sfuso all’imbottigliamento. «Mio padre si avvalse anche per questa importante fase del “tuttofare” Vito Nicassio, detto “Maccone” – racconta il giovane –: un uomo di fiducia al quale abbiamo intitolato la nostra etichetta più conosciuta».
E mentre notiamo i dipendenti riempire le damigiane di vetro, ci rechiamo nella stanza dei silos in acciaio, utilizzati per la fermentazione e la conservazione. Scendendo alcuni gradini arriviamo poi nella parte interrata dove in un lungo corridoio ammiriamo i bocchettoni di apertura delle grosse e vecchie vasche di cemento della capacità di centinaia di ettolitri, che qui, come da Colavecchio, sono ancora usate in alternativa ai silos.
«L’identità degli Angiuli – conclude il proprietario –, sta proprio nei metodi di vinificazione tramandati di padre in figlio e mai svelati a nessuno, nemmeno agli enologi che collaborano con noi, i quali con le loro procedure standardizzate rischierebbero di snaturare il nostro prezioso primitivo».
(Vedi galleria fotografica)
© RIPRODUZIONE RISERVATA Barinedita


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)